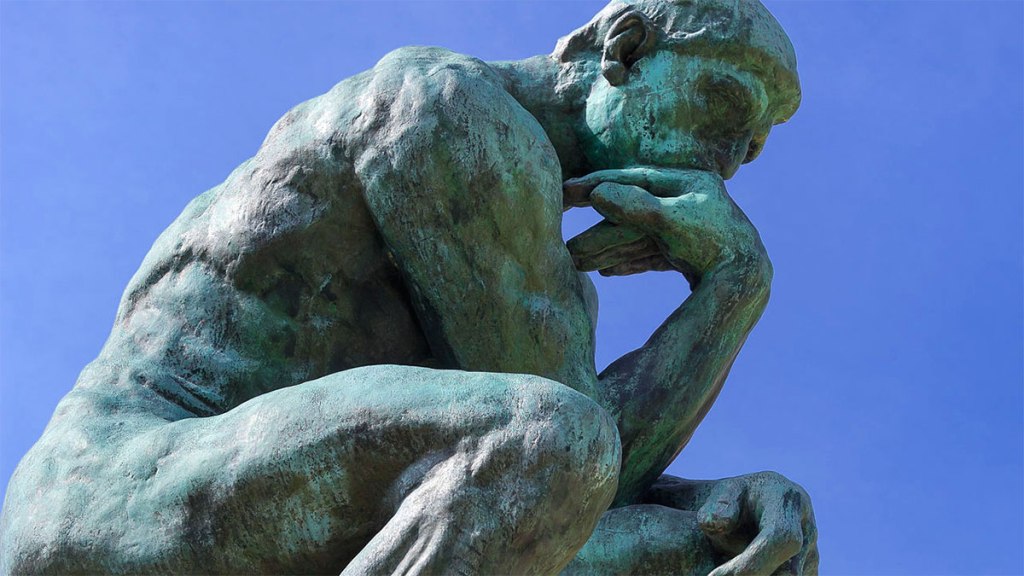Poiché il tema degli intellettuali è cruciale nella mia personale agenda, e ne ho molto scritto qui su HR, sentendomi stimolato dal post di Ottonieri faccio una postilla. Prima alcune premesse:
- condivido il testo di Ottonieri e pregherei il lettore di prenderne visione, prima di leggere il mio;
- una mia riflessione generale è già stata scritta QUI e non vorrei ripetermi, e se non chiedo troppo al lettore, e ammesso che abbia tempo e un buon caffè davanti, sarebbe utile anche un’occhiata a questo testo.
Ottonieri – dopo avere constatato l’incapacità degli intellettuali di coniugare la competenza nel merito degli scienziati a quella relazionale degli umanisti – chiede che la scuola aiuti a fare circolare questi due tipi di sapere: un po’ più di sociologia e filosofia nei giovani destinati a fare gli scienziati, e un po’ più di matematica e scienze per i futuri sociologi e filosofi. Sono d’accordissimo, ma ahimè non basterebbe. Avremmo sociologi meno confusionari e fisici meno ottusi riguardo il resto del mondo, ma non necessariamente degli intellettuali.
Bisogna definire intellettuali, e lo farò aderendo convintamente a quanto Ottonieri ha scritto:
qualcuno che partendo da un suo patrimonio culturale è in grado di leggere e interpretare una realtà complessa e di trasmettere questa interpretazione agli altri (idealmente, a tutti; nella realtà concreta, a chi abbia gli strumenti minimi per comprenderlo).
Perché ci servono queste persone? Perché “interpretano e trasmettono” il senso della complessità “agli altri”, ai non intellettuali (ma – come sottolinea Ottonieri – che abbiano “gli strumenti minimi per comprenderlo”).
Mentre scrivo mi viene l’analogia coi mediatori culturali, gli interpreti, i traduttori… Costoro non sono portatori di un algoritmo per il quale incontrando “table” traducono “tavolo” e incontrando “sessel” traducono “sedia”; il bravo interprete conosce la cultura dell’altro popolo, vi si compenetra, comprende il contesto in cui quella parola, quella frase, sono inserite, ha sensibilità per capire il senso che l’autore di quel testo voleva dare e quindi offre non già una mera traduzione letteraria (cosa che ormai il traduttore Google fa abbastanza bene) ma la trasposizione di quel senso straniero in un analogo (mai identico) senso italiano. Un esempio estremo ma credo chiarificatore: la traduzione di Umberto Eco agli Esercizi di stile di Queneau sono tutto fuorché una traduzione pedante dal francese.
L’intellettuale, quindi, è un interprete del mondo capace di dargli un senso (uno dei possibili) in maniera comprensibile a una platea di persone che altrimenti faticherebbero a trovarlo. L’intellettuale – come l’interprete – non è un dispensatore di verità ma un organizzatore di senso; può darsi benissimo che sbagli, che non colga tutti gli elementi di quella data “verità” e così via, ma sapendone produrre un senso contribuisce a farne produrre uno simile ai suoi interlocutori, e la sua funzione è nella produzione, e non nel risultato. I suoi meriti non sono indicare la verità, ma indicare una strada per avvicinarvisi. Il suo ruolo è indicare un metodo, un metodo nel pensiero, ed è il metodo a implicare una scintilla di verità, e non necessariamente la conclusione alla quale quell’intellettuale, coi limiti della sua umanità, crede di avere raggiunto.
E cosa sarebbe questo “metodo nel pensiero”? Non è poi così difficile immaginarne almeno alcune caratteristiche:
- fonti verificate (per l’umanista) o fatti sperimentali (per lo scienziato);
- argomentazione priva di fallacie logiche.
Le fonti verificate sono un bel dire, ma sono sempre e solo ipotetiche; se parliamo di fatti sociali (di cronaca, politica, costume) abbiamo sempre e solo resoconti di giornalisti che possono avere frainteso, possono essere frettolosi, possono addirittura contenere delle falsità. Indubbiamente si possono incrociare più fonti di informazione generalmente reputate adeguate, ma questo vale solo per i fatti. Gran parte della nostra socialità non si manifesta con dei fatti “cinetici” (manifestazioni di piazza, per esempio) ma con dei pensieri che diventano fatti a ragione delle loro conseguenze (la dichiarazione di Cacciari, per esempio). Se io critico il pensiero di Cacciari, devo rimanere entro gli schemi di pensiero di Cacciari, dare sentore di verità oggettuale al suo pensiero per esaminarlo e coglierne, per esempio, delle fallacie (che è il prossimo punto). Né ci aiutano, per i medesimi motivi, i fatti sperimentali; il Covid 19 non ha creato lo scalpore mediatico che ha creato per il virus in sé, ma per le sue conseguenze sociali (malattie, morti, chiusure economiche) e per le conseguenze di conseguenze (decisioni politiche da prendere per limitare i danni). I fatti sperimentali riguardano la virologia, la farmaceutica e quanto di scientifico si è fatto per trovare una cura e curare i malati, ma i no vax, i virologi in TV, i rovelli del Ministro Speranza, l’opposizione di Salvini alla mascherina etc., hanno solo marginalmente a che fare con qualunque evidenza sperimentale lo scienziato possa mostrare, divenendo immediatamente questioni sociali da interpretare.
Più importante, quindi, è l’argomentazione priva di fallacie. È qui che incontriamo Cacciari, Burioni e Meloni, Travaglio e Murgia, e tutti, tutti, tutti coloro che aprono bocca per dare un loro parere su qualunque argomento, e che noi vorremmo indicare come “intellettuali” ma no, come ha sottolineato Ottonieri, raramente lo possiamo fare. In alcuni casi (Cacciari, Agamben…) sì, è la loro ignoranza scientifica che li fa cadere nella più banale delle fallacie, ovvero dire cose false credute per vere (ciò capita parlando del Covid 19 e di cosa farebbe o non farebbe, i vaccini, le mascherine, etc.). Ma la gran parte delle fallacie non sono così facili da smascherare e hanno natura prettamente linguistica (ne ho parlato QUI e in diversi altri post), nascosta sotto montagne di retorica, fuffa sintattica, capriole verbali, esercizi di stile (non certo quelli di Queneau) che il lettore medio fatica a discernere e interpretare per quello che sono: boiate.
Mi scuso per le ipersemplificazioni, fatte a beneficio della pazienza del lettore, ma il senso, spero, è abbastanza chiaro.
Torniamo all’intellettuale e alle qualità che, quindi, dovrebbe avere (e che così raramente troviamo nei presunti intellettuali italiani):
- competenza scientifica quando parla di questioni scientifiche;
- capacità comunicativa, empatia, assunzione di un ruolo di “mediatore della complessità”.
E fin qui non c’è nulla di nuovo rispetto a quanto ha scritto Ottonieri; ma io vorrei aggiungere, semmai come semplice sottolineatura, almeno questa qualità:
- indipendenza intellettuale.
L’indipendenza intellettuale non è quella manifestazione del carattere per la quale sei necessariamente sempre polemico o sempre in disaccordo o sempre “contro” (il sistema, la casta, la dittatura sanitaria…), che anzi, a mio parere, la maggior parte delle persone sempre polemicamente ostili sono nella maggior parte dei casi degli omologati.
L’indipendenza di cui parlo (da anni) è una qualità dello spirito che si dispone alla mediazione sopra descritta privandosi di schemi ideologici, senza tesi da dovere dimostrare, senza necessità di piantare una bandierina identitaria. Quindi l’intellettuale di oggi – a mio avviso – prima di essere un mediatore della complessità è un ricercatore nella complessità, e il suo cercare è motivato dal fatto che non ha già una verità (presunta tale) da argomentare capziosamente e da dimostrare al popolo. No, quindi, a tutti gli “-ismi”; se devi dimostrare una verità liberista, o femminista, o marxista, o terzomondista (o fascista, ça va sans dire, ma neppure scient-ista) non stai più mediando fra la complessità e la possibilità di comprensione dei tuoi interlocutori, ma sei un manipolatore, una persona di vedute limitate, una persona che non cerca nulla perché ritiene di avere già una Verità acquisita, che semplicemente applica ripetitivamente e ritualmente a ogni circostanza, una cosa non diversa da quello che fanno i talebani, i cosiddetti “studenti del Corano” che imparano a memoria qualche versetto del loro libro sacro e intendono imporlo a ogni fatto, a ogni circostanza.
Ecco, in linea di massima una grande fetta dei presunti intellettuali italiani contemporanei non hanno questa indipendenza intellettuale (che è anche morale) e quindi non sono mediatori della complessità ma, a loro volta, elementi di complessificazione.
Vorrei concludere con l’unico punto in cui non concordo con Ottonieri, perché lui è un razionalista ottimista o io un nichilista ormai perduto: questa indipendenza intellettuale non si insegna nei licei. Non basta insegnare filosofia o sociologia ai futuri fisici, o matematica e fisica ai futuri sociologi: così li rendiamo più colti e meno sprovveduti a fronte di certe possibili fallacie. Che è certamente già un buon risultato. Ma l’indipendenza intellettuale, onestamente, non credo si possa insegnare. L’intellettuale diventa indipendente (e quindi un buon mediatore della complessità) per un un tale aggrovigliato insieme di qualità, condizioni, circostanze, accadimenti (e ardimentosi percorsi interiori), che onestamente la formula chimica di questo casuale ed episodico successo non l’ho neppure capita bene. L’unica cosa che credo di capire è che per qualche ragione, in questo momento storico, oltre a Cacciari, Murgia, Travaglio e Mieli non riusciamo ad andare, e il nostro popolo ne paga con tutta evidenza il prezzo.